Riflessioni sul doppiaggio nel cinema italiano
4 Febbraio 2008
La tecnica del doppiaggio, a partire dagli anni 50, si sviluppa e perfeziona di pari passo con la massima stagione del cinema italiano, ma finisce allo stesso tempo per provocare riflessioni a livello commerciale e finanche ideologico e politico sullo specifico filmico; si parla qui naturalmente non degli attori che doppiano se stessi, ma di voci di soggetti che prestano le proprie inflessioni ad altre facce, sia nel cinema italiano che nella distribuzione italiano dei film stranieri.
Il punto, a parere di chi scrive in base ai dati appresi, è questo: a cavallo tra gli anni 50 e 60 si affermano grandi personalità registiche che per motivi diversi ritengono la tecnica del doppiaggio assolutamente necessaria per veicolare il proprio messaggio filmico (posto che a livello generale la presa diretta non veniva quasi considerata). Elenco a mo’ di esempio alcuni autori che più si sono avvalsi, per vari motivi, di questa tecnica:

2. Luchino Visconti: Anche il regista lombardo, grande perfezionista ma metteur in scene per propria cultura di pellicole che riunivano cast internazionali (America, Francia, addirittura la Grecia con Katina Paxinou, la madre dei fratelli Parondi) per motivi simili sceglieva di unire alla faccia dolente di Delon in Rocco e suoi fratelli una voce meridionale come quella di Achille Millo e di dare al fratello antagonista Simone (Renato Salvatori) il tono stupito dell'attore pugliese Riccardo Cucciolla per l'improvvisa "abbondanza" dell'ambiente circostante.
3. Pier Paolo Pasolini: forse il regista più “costretto” ad utilizzare la tecnica del doppiaggio, posto che per esplicita scelta artistica molti dei soggetti utilizzati per i suoi film erano letteralmente e non metaforicamente presi dalla strada; basti pensare al Cristo de Il Vangelo Secondo Matteo, uno studente spagnolo a cui anche qui Enrico Maria Salerno presta stavolta accenti sferzanti per evidenziare gli insegnamenti del Cristo.
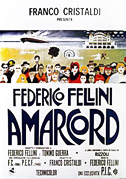
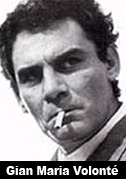
Il punto è che, a partire dalla fine degli anni 60 (mentre l’industria cinematografica è al top in tutti livelli), dall’ultimo successo di Antonioni alle decine di film di Franco e Ciccio si levano delle voci di dissenso nei confronti di tale pratica che, a parere di alcuni, è anche un modo per permettere ad attori minori frustrati di far sentire la propria voce e a facce gradevoli, magari straniere (ricordiamo che in quel periodo erano tantissime le coproduzioni per esempio con la Francia) di evidenziare una recitazione che nella realtà non esisteva perché le emozioni erano veicolate da terzi.
Promotore di questo dissenso è soprattutto il già citato Gian Maria Volontè, il quale negli anni 70 inizia un braccio di ferro con i produttori ed in genere l’establishment cinematografico per far sì che sia confermata una volta per tutte l’unione tra la voce ed il volto dell’attore; com’era facilmente prevedibile, i suoi sit-in ed i dibattiti da lui promossi gli causano ostracismi ferocissimi da parte dell’ambiente cinematografico che gli impediranno di fatto, per un certo tempo, di lavorare in Italia.

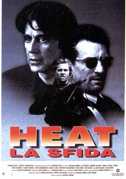
Di certo la questione del doppiaggio e dell’unione voce-volto attualmente si è molto affievolita, anche perché l’avvento del supporto dvd permette a chi lo desidera di seguire un film con le tracce originali. Resta da rilevare, invece, che adesso si è affermato il filone della voce "guest star", ovvero della voce di un personaggio famoso (non necessariamente un attore professionista) che presta la propria voce di solito in un film di animazione: si pensi ad esempio a Toy Story, dove i protagonisti sono doppiati da Massimo Dapporto e da Fabrizio Frizzi.
ARTICOLO INSERITO DALLA BENEMERITA GUGLY



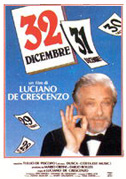


13 Aprile 2012 22:24