Cinema italiano e lavoro
14 Giugno 2008
In Italia da qualche anno si fa un gran parlare della questione lavorativa, in particolare per quanto riguarda la generazione dei 25-30enni, descritti come eterni precari e incapaci di risorse ed intraprendenza.
Dato che il cinema è (o dovrebbe essere) lo specchio della società, chi scrive si chiede se il cinema italiano abbia affrontato la questione e quali conclusioni se ne siano tratte.
La premessa è lunga e parte da un dato oggettivo: della questione lavoro tout court il cinema italiano ha avuto difficoltà ad occuparsene, prova ne sia il clamoroso flop che accompagnò l’uscita del film
I compagni (1963) di
Mario Monicelli, completamente dedicato alle lotte operaie avvenute sul finire del secolo XIX.
E’ invece più facile che la questione lavorativa sia stata unita ad altri elementi drammaturgici come il melò, il quale volgendo il peculiare filmico in direzione di temi più universali (l’amore, l’amicizia, ecc.) aveva maggiore garanzia di attrarre lo spettatore (il pensiero corre a film come
Metello).
Per arrivare ad una epoca più recente, bisogna ammettere che finora c’è stato un unico regista in Italia che abbia messo al centro delle sue pellicole con una ragionevole verosimiglianza la questione lavorativa: si sta parlando, come è facile comprendere, di
Paolo Virzì, considerato l’erede della grande commedia all’italiana degli anni 60; a ben vedere, per mentalità e ancor più per tradizione storica, in Italia la denuncia delle storture sociali è avvenuta in larga parte attraverso commedie, quasi mai drammi (se si eccettua il filone civile che è un caso a parte), tutt’al più abbiamo avuto qualche film grottesco di autori come
Petri (
La classe operaia va in Paradiso).
Virzì fa propria quest'ottica e ci consegna tre film in cui l’influenza dell’apporto lavorativo condiziona i personaggi ed i rapporti tra soggetti e tra soggetto ed ambiente: sto parlando come è chiaro di
La bella vita,
Ovosodo e del recentissimo
Tutta la vita davanti, dedicato completamente al fenomeno del precariato.
La bella vita è a ben vedere uno dei pochi film che ci mostra in modo sobrio e non tragico o grottesco cosa può succedere quando un posto di lavoro sicuro (il posto di operaio al centro di significative battaglie storico-sociali) all’improvviso non è più tale ed esclude l’individuo da un universo che si credeva stabile e inamovibile; certo, mescola altri temi come l’abbaglio di un’altra vita magari accanto ad un imbonitore televisivo, i rapporti amorosi, ma il motivo scatenante che dà il la a tutta la vicenda è la cassintegrazione di
Bruno (un bravo
Claudio Bigagli, strano toscano sommesso almeno fino a quando non scopre l’infedeltà della moglie).
Il discorso si fa ancora più chiaro in
Ovosodo, dove la vita del giovane
Piero Manzani (un disincantato
Edoardo Gabbriellini) viene di fatto influenzata dalla fabbrica adiacente al quartiere che dà il nome al film, sia a livello di rapporti personali (l’amico
Tommaso è figlio del proprietario della medesima) che di destino:
Piero dopo molte vicissitudini finirà a lavorare proprio nella fabbrica in questione, prima operaio (si presume ancora stabile dati i tempi) e poi come impiegato, e può addirittura permettersi di mettere su famiglia con figlioletta al nido; il film sembra già preistoria, ma è stato girato nel 1997.
Tutta un’altra musica con l’ultima fatica
Tutta la vita davanti, in cui viene affrontato di petto il precariato, visto come una giungla dove ad emergere non è il più preparato ma il più faccia tosta (possibilmente ammanicato con qualcuno che conta) e chi riesce a fare le scarpe agli altri senza sensi di colpa e soprattutto senza farsi scoprire: la protagonista si aggira in questo strano mondo che sembra una propaggine dei
reality show che tanto raccolgono consensi fra i più giovani come
Alice nelle paese delle meraviglie… L’unico problema è che il cibo te lo devi procurare con le unghie e con i denti, e non vale un bel voto di laurea, vale quanto riesci a sottostare a rituali e ritmi assurdi che non concepisci ma che sei costretto ad accettare se vuoi guadagnare qualcosa.
Il merito di
Virzì è di averci mostrato tutto questo, anche se alcune pecche ci sono: il sindacalista di
Mastandrea ad esempio non rifugge da un macchiettismo vitellone degno di migliore sviluppo, e in tutti e tre i film il finale è consolatorio come nella migliore tradizione del volemose bene… Ecco, sarebbe auspicabile un maggiore coraggio; anche se, visti i tempi che corrono, pure così è meglio di niente.
ARTICOLO INSERITO DALLA BENEMERITA
GUGLY 

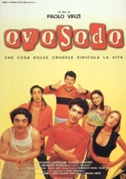







11 Dicembre 2019 08:57