Altman '70, contemplando i castelli di sabbia
29 Novembre 2012
Quando si parla di cinema indipendente americano si ha ormai l’impressione di qualcosa di alternativo nei contenuti ma inserito all’interno di un circuito ben oliato quanto quello “mainstream”.
La nascita di festival (il
Sundance, solo per citare il più celebre) mirati alla diffusione del cinema “libero” ha contribuito alla normalizzazione di quello che è finito col diventare un genere a sé. Via via celebrando autori (e presunti tali) del nuovo cinema slegato dal potere delle major, si è finiti per codificare tacitamente ciò che doveva rappresentare, per definizione, l’essenza stessa della libertà di espressione.
Esplorando le origini di questo particolare fenomeno cinematografico, non vi è dubbio che tra i registi storici e più veri che l'hanno rappresentato vi sia Robert Altman. Dai primi passi quasi ignorati (
Conto alla rovescia, dal quale fu poi esonerato) ai grandi successi di pubblico (
M*A*S*H), dai periodi d’oblio (
Streamers) alle grandi rentrée (I protagonisti), Altman è un regista che ha sempre fatto il suo cinema, portando avanti tematiche - coerenti con stili ed ambientazioni - molto innovative, senza curarsi troppo di critica e pubblico, da sempre rifugio di preconcetti e volubilità.
Il regista di Kansas City è stato un indipendente per necessità (di budget) e per volontà (di contenuti) quando non era una moda esserlo, quando la chimera dei registi era Hollywood e in onore a Hollywood andavano piegate tutte le attitudini personali.
Nonostante le diversità apparenti nelle tematiche affrontate dal suo cinema, un filo rosso lega la maggioranza dei film di Altman: un discorso intenso e crudele sulla violenza contemporanea e sui suoi effetti devastanti quando irrompe, inattesa, nella quotidianità. Una quotidianità fatta di apparenze e omologazioni che lascia ben poco spazio ai sognatori, quelli che per ingenuità o incoscienza non si lasciano imbrigliare dal pensiero comune ma continuano a testa bassa la loro battaglia contro i mulini a vento; quelli che non sanno quando è l’ora di lasciar perdere ma anzi finiscono col perdersi, nella rincorsa disperata dei loro desideri. Sono questi i veri eroi altmaniani, eroi che non verranno mai celebrati, semmai biasimati.
Lo stile narrativo del regista di
M*A*S*H è sempre stato teso a catturare la spontaneità più che a riprodurla. In sosituzione di immagini pulite e dialoghi ben definiti e chiari, troviamo spesso sovrapposizioni di volti e voci, audio multitraccia dove non tutti i dialoghi si capiscono per intero, riflessi di volti che prendono il posto di primi piani. Uno stile nel quale il commento sonoro si deve amalgamare con la realtà e le musiche (non troppo insistenti) hanno il fine unico di aiutare lo spettatore a restare più concentrato nella visione. Altman sembra a volte non curarsi troppo della “confezione musicale” ma arricchisce i suoi film con piccole, magnifiche canzoni che poi finiscono per diventarne il manifesto.
Di seguito andremo ad analizzare i titoli della filmografia anni '70 del regista; opere che ben delineano lo stile graffiante e irriverente del regista, il suo approccio innovativo e il suo amore per i personaggi e gli attori, sempre più importanti delle storie raccontate. Tutto questo nel tentativo di mettere a nudo l’anima nera che ha tormentato il sogno americano in ogni sua stagione. Inutile dire che il rischio di svelare parti importanti e finali dei film è presente.
Con
M*A*S*H (1970) Altman ottiene per la prima volta il grande successo: una graffiante satira sulla guerra, vista dall’opposto degli ideali di valore e orgoglio tipicamente americani. Se è vero che l’ambientazione parla di Corea, in realtà tutto verte attorno alla spinosa questione del Vietnam, in quegli anni caldissima. Il punto di osservazione è uno strampalato ospedale chirurgico mobile dell’esercito U.S. posto poco lontano dalle linee di fuoco. L'apparente tranquillità posta nell'occhio del ciclone è turbata in ogni istante dall’arrivo di corpi devastati e pezzi di carne; un gruppo eterogeneo di medici ed infermiere vivono, ognuno a modo proprio, il dramma della guerra di cui vedono sempre e solo gli effetti più devastanti. L’ironia, gli scherzi e le battute, i giochi e le beffe, sono gli unici espedienti per salvare la propria sanità mentale; senza riverenze militaresche, in un confine ormai oltrepassato dove la guerra non può più trovare alcuna giustificazione politica.
Indimenticabile l'improvvisata quanto curatissima rappresentazione de L’ultima cena di Leonardo in camici bianchi, che prelude al finto funerale di un aspirante suicida, cerimonia attraverso la quale tutti i compagni sdrammatizzano ed esorcizzano il momento di scoraggiamento dell’amico, facendogli trovare in seguito (anche con l’aiuto di un’avvenente soldatessa) la voglia di ricominciare. Il tutto incorniciato dall'indimenticabile
“Suicide is painless”.
Dello stesso anno è la favola grottesca
Anche gli uccelli uccidono (
Brewster McCloud, 1970) in cui il protagonista, Brewster, è un giovane che insegue un sogno grande; il più grande sogno dell’uomo: Il volo.
Il volo degli uccelli, che Brewster studia con febbrile impegno, è anche la fuga da una realtà piatta e preordinata. Intorno a lui una serie di personaggi grotteschi, spesso meschini, che in un modo o nell’altro cercano di ostacolare il suo sogno. Dalla sua parte solo Louise, bella ed etera figura femminile che gli fa da angelo custode (sarà per quello che ha delle cicatrici sulla schiena, forse ali mozzate) e che cerca di fare in modo che le distrazioni, prevalentemente dovute alla scoperta del sesso, non lo distolgano dal suo obbiettivo. “La gente accetta quello che gli viene detto. Non pensa di essere libera, non pensa neanche di poterlo essere. L’amore è la cosa più vicina che hanno al volo. Crescono e l’amore diventa sesso e allora vanno sempre più verso la terra. Sperimentato il sesso si adattano a quello, e generano altra gente come loro.”
Louise in Brewster McCloud. Una serie di misteriosi omicidi farà piazza pulita di tutti coloro che si metteranno di traverso tra Brewster e il suo volo. Ad indagare sui delitti un super poliziotto, sorta di parodia dello sbirro implacabile dei film americani anni ’70, che però finirà (tra il tragico e il comico) suicida dopo un inseguimento con parecchie vittime (reazione di Altman all’assurdità di certi polizieschi, nei quali nessuno si preoccupa dei morti che man mano si accumulano).
Poco prima della prova della vita, Brewster conoscerà l’amore e l’abbandono (da parte di Shelley Duvall) e arriverà al momento tanto atteso senza la purezza e ingenuità che lo avrebbero forse sostenuto (e soprattutto senza la presenza di Louise, delusa e uscita di scena). Il giovane si troverà nell’auditorium di Huston (sorta di immensa gabbia) a volare con le ali da lui fabbricate fino allo sfinimento e all’inevitabile, mortale caduta. La polizia, il mondo razionale, la società, attenderà la fine del volo, fucili in mano. Sul silenzio che segue la caduta al suolo del giovane, nel momento in cui giace a terra esanime, si apre il più felliniano e beffardo dei finali mai creati da Altman: l’entrata di una banda e di un presentatore in stile circense inizia a riempire di fragore la silenziosa gabbia: tutti i personaggi del film vengono presentati (con il vero nome di chi li ha interpretati) e anche il povero, immobile Brewster/ Bud Cort avrà così il suo momento di gloria.

L’anno successivo, con
I Compari (
McCabe & Mrs. Miller, 1971), il regista fa capolino nel western, naturalmente a modo suo. I tempi degli impavidi eroi della frontiera americana sono lontani anni luce; difficile scorgere echi degli epici scontri tra sceriffi alla Wyatt Earp e pendagli da forca o assalti indiani alle diligenze sventati dalla cavalleria. Il west di Altman è il luogo degli emarginati, degli uomini comuni che lavorano in una piccola, inospitale comunità sepolta tra gli alberi e la neve; poveri diavoli che come sfogo possono avere solo l’alcol e forse un bordello nuovo di zecca. Tra queste solitudini si muovono i protagonisti: una Julie Christie pragmatica ma sentimentale e un Warren Beatty uomo d’affari sognatore, preceduto da una fama più grande di lui con la quale fatica a confrontarsi. L’amore silente che nasce tra i due giace sotto la coltre di incomunicabilità (e freddo) che pervade il film. Un western crepuscolare, in cui tutti sono sconfitti fin dal principio, in cui non c’è posto per la gloria o la vendetta ma solo per il rimpianto. Ancora una volta le splendide immagini (dal bianco degli esterni ai colori bruciati e quasi caravaggeschi degli interni) e la vicenda narrata lasciano posto nella memoria agli splendidi personaggi, raccontati nel loro sogno di gloria (o forse solo di quiete) infranto. Una vicenda intrisa di solitudine che culmina nel duello finale, con il protagonista che, dopo aver eliminato i nemici, si accascia e muore nell’indifferenza. Un esempio di brutale violenza (più volte presente nei film di Altman) scuote gli spettatori nella scena in cui il giovane Carradine viene ucciso lungo un ponte di legno, senza motivo, solo per la volontà di sfogarsi del più giovane fra i killer arrivati in città. Una morte assurda commentata dal silenzio e dall’incredulità.

Con alcuni debiti di riconoscenza a film che trattano simili tematiche (da Bergman a Polanski),
Images (1972) si staglia nel panorama del cinema altmaniano come una delle pellicole più ambiziose e sottovalutate. Visivamente intenso (con immagini di un color ocra predominante) e acusticamente ossessivo (vi sono più rumori che musiche), questo piccolo grande thriller della mente ci regala sorprese in ogni fotogramma e ci permette di ammirare il talento del regista nel creare situazioni e ambientazioni pesanti, dolenti, ben lontane dalla goliardia di suoi lavori più celebri. La vicenda di Chatryn, la sua malattia, le voci e le figure che la circondano e la sospendono in un limbo tra mente e corpo, sono un’unica grande accusa alla provvisorietà delle relazioni umane e alla loro assoluta fragilità. L’ancora di salvezza è (forse) l’amore materno, unico e granitico, un amore che se non trova sfogo può però condurre alla pazzia. Tutto conduce lo spettatore (con la protagonista) verso un senso di claustrofobia (nonostante come location siano utilizzati gli spazi aperti d’Irlanda). Tra immaginario e reale il confine diventerà sempre più esile, fino a confondersi del tutto.

Dopo questa parentesi psico-intimista è il momento de
Il lungo addio (
The long goodbye, 1973), uno dei migliori lavori di Altman. Un film che sintetizza il suo modo di fare cinema e che, nell’esito finale, appare come uno dei più completi. Lo scanzonato Marlowe, ottimamente tratteggiato da Elliot Gould, è quanto di più anticonvenzionale si sia visto tra i detective americani, e il suo muoversi ingiacchettato, tra bikini e costumi sotto il sole della California, lo fa apparire quasi un personaggio fuori dal tempo catapultato lì da un’altra epoca. L’intreccio giallo ovviamente è un pretesto, ma tutto verte attorno al senso di solitudine del detective, che si riflette anche sul suo rapporto con il gatto (presente solo quando ha voglia di mangiare). L’amicizia tradita, i giochi meschini, i gangster da strapazzo e le bugie troveranno risposta in Marlowe nella brillante scena finale, dove finalmente e inaspettatamente reagirà. La meravigliosa fotografia dai colori forti, quasi bruciati (ottenuti esponendo la pellicola alla luce prima di svilupparla, come già fatto ne I Compari) ben rende la calura, il senso di oppressione e l’effetto retrò voluto dal regista. Marlowe per tutto il film è sulla scena e noi con la camera lo seguiamo come dei voyeur. Solo in un’occasione sarà fuori campo (a passeggiare sulla spiaggia mentre lo scrittore Roger Wade/Sterling Hayden, figura ispirata ad Hemingway, sta facendo il suo monologo alla finestra), eppure con un abile gioco di riflessi il regista lo farà rimanere comunque visibile a tutti.

Una pellicola fortemente voluta dal regista (che per realizzarlo si accordò con la produzione accettando di girare Nashville) è
Gang (
Thieves like us, 1974). Cercando di assecondare il filone criminale in voga in quegli anni (erano ancora forti gli echi di
Gangster story) ma non snaturando i suoi veri interessi narrativi, Altman confeziona una vibrante storia di amore, miseria e violenza. L’arretrato Mississippi fa da sfondo alle disgraziate avventure di un terzetto di evasi che, da una rapina all’altra, seminano terrore e violenza sempre più gratuite. Keith Carradine (riconfermato dopo I compari) è l’elemento più giovane ed ingenuo del trio. Ragazzo spavaldo ma in cerca di riferimenti, finisce per assecondare i due più attempati complici anche quando la situazione sfugge loro palesemente di mano. In tutto questo l’amore tra il giovane e (l’ormai abituale) Shelley Duvall sarà un rifugio di pace nel caos, una speranza per resistere alla deriva, un’occasione non colta. I criminali di Altman sono specchio della miseria americana post depressione, in cui la violenza era accettabile, se necessaria alla sopravvivenza. Le scorribande della gang partono come un gioco, in un clima quasi goliardico, ma cambiano presto d’aspetto, facendoci osservare i protagonisti sotto una luce più vera e triste.

Il 1974 arriva sugli schermi
California Poker (
California Split, 1974), in cui un misurato George Segal e un incontenibile Elliot Gould sono protagonisti di un film che illumina l’universo delle sale da gioco e (più genericamente) del mondo dell’azzardo. I ritmi sono quelli della commedia, con l’incontro di due personaggi molto differenti che socializzano per inseguire il sogno comune, quello di sbancare. Il caos delle corse, dei casinò e delle case da gioco (più o meno legali) sono il comune denominatore di una pellicola “sonora” e movimentata. Il feeling tra i due protagonisti è palpabile e l’istrionico Gould non smette per un attimo di parlare. In quest’habitat caotico si muovono personaggi apparentemente scanzonati ma profondamente insoddisfatti, sempre alla ricerca del colpo di fortuna che cambierà loro la vita, ma soprattutto di quell’emozione data dalla vincita e dall’attesa della stessa. Altman affronta ed esorcizza così una sua passione, quella per il gioco, che in alcune persone rischia di diventare ossessione, la brama di una svolta che potrebbe non arrivare mai. Tra fumo, alcol ed euforia, i nostri eroi rappresentano tutti quelli che dal gioco si aspettano le emozioni che mancano loro nella vita, sensazioni che superano anche il valore intrinseco del denaro vinto. Emozioni vuote e temporanee che danno vita allo splendido finale del film in cui, alla fine di una serata epica dove finalmente ha vinto più di quanto avesse mai immaginato, George Segal appare svuotato e, sotto gli occhi dell’attonito Gould, si rifugia da solo in una stanza. Nessuna sensazione grandiosa. Il sogno, ora che è raggiunto, si rivela effimero e apre agli occhi del protagonista la vacuità della sua vita.

Il 1975 è l’anno di
Nashville, pellicola particolare e contraddittoria che, pur nata su commissione, finisce col diventare uno dei più celebrati film di Altman. In questo film – tributo alla canzone folk americana e al suo regno (la città di Nashville, appunto) il regista statunitense può cogliere l’occasione di unire la sua ambizione di girare finalmente un film corale con quella di dare maggior spazio a suoni e voci mescolate vorticosamente, spiando curioso brandelli di vite che si intrecciano in un caos creativo dominato da personaggi e canzoni uniti indissolubilmente. Nel calderone di musica e costume americano non possono mancare i richiami all’onnipresente politica, incarnata da un camioncino elettorale che funge da atipico filo conduttore degli eventi, finendo per influenzarli. Pur avendo riscosso un buon successo, tanto da diventare il marchio del cinema altmaniano, per molti versi si tratta di una pellicola poco personale e troppo incentrata su personaggi numerosi ma poco approfonditi. Il tocco beffardo del regista è palpabile comunque in molte situazioni (una su tutte il surreale canto finale, cornice idilliaca che allontana le nubi dell’omicidio di un’innocente: lo spettacolo deve continuare).

“La storia viene prima della verità” sembra il motto ideale per il film dell’anno successivo:
Buffalo Bill e gli indiani (Buffalo Bill and the Indians, 1976). Il mito americano, l’essenza stessa dell’orgoglio nazionale e della storia statunitense, viene messa alla gogna in questo insolito film dedicato alla figura celebre di William Cody. Buffalo Bill ci appare come un simpatico guascone lontano dall’aura mitica che si è cucito addosso: un uomo debole, rozzo, che fatica a confrontarsi con una figura grandiosa (la sua) che evidentemente gli è sfuggita di mano. Il suo incontro con il capo indiano Toro Seduto gli darà modo di interrogarsi sulla differenza tra storia (ufficiale) e realtà, uscendone malconcio. Il pubblico del baracconesco spettacolo “The Buffalo Bill wild west” rappresenta il popolo americano, sempre in cerca di miti che giustifichino una storia nazionale fatta di sopraffazioni. Un pubblico che vuole vedere gli indiani come selvaggi stupratori e assassini, niente di più. Il film, uscito nel periodo del Watergate, andò a sbeffeggiare un’America già pesantemente umiliata dagli scandali politici e non riscontrò ovviamente molto favore, in patria.

Dopo l’insuccesso di questa rivisitazione storica, tornano le atmosfere rarefatte e oniriche delle opere più intimiste di Altman in
Tre donne (
Three women, 1977). La vicenda ruota attorno a tre figure femminili molto differenti ma che insieme si completano: la timida e ingenua Pinky, la superficiale e spregiudicata Millie e l’enigmatica Willie intrecceranno un rapporto i cui equilibri muteranno in seguito ad eventi tragici. Pellicola oscura, a tratti indecifrabile, Tre donne come Images ha nell’ermetismo estremo il suo pregio e il suo difetto, ma di sicuro è un lavoro che non lascia indifferenti e ancora una volta fa bella mostra delle potenzialità di un regista eclettico ed estremamente dotato. Una storia femminile e femminista in cui i personaggi maschili sono bidimensionali marionette di scarsa importanza narrativa.
Nel successivo
Un matrimonio (
A wedding, 1978), abbandonate le atmosfere oniriche, la propensione nei confronti dell'opera corale di Altman si esalta come non mai: il regista approfitta dell’occasione per dirigere un’intera orchestra di attori: dai ventiquattro personaggi presenti in Nashville passiamo a ben 48 soggetti attivi, tutti chiusi in una villa a celebrare un matrimonio. Il regista si concentra ancora una volta sul collettivo, le voci, la confusione dovuta alla simultanea presenza di tanti interpreti a briglia sciolta. Il matrimonio diventa solo un mezzo per aprire il sipario sulle speculazioni, le piccole grandi meschinità e l’ incertezza di una classe media multiculturale in ascesa economica ma non sociale. Incontenibili gli attori (Gassman e Proietti su tutti), voyeuristica la macchina da presa ed evidentemente incoraggiati i momenti di improvvisazione.
La successiva prova registica si rivela una curiosa incursione nel post-apocalittico: nell’insolito
Quintet (1979) si riforma la coppia Altman/Newman. Il film, la cui idea nasce da un sogno del regista, ci regala una (possibile) umanità futura che vive in un pianeta ormai congelato da ghiacci perenni. Gli abitanti di queste isolate comunità conducono un’esistenza senza grosse speranze e con una natalità azzerata. Unico collante sociale, uno spietato gioco di ruolo che può determinare la loro vita o morte. L’arrivo dello straniero Newman e la scoperta della possibile gravidanza di una giovane donna getteranno scompiglio nella gelida routine locale. Il film si rivela coraggioso e originale per l’epoca ma non raccoglie molto successo in patria, facendo tornare quindi al regista voglia di leggerezza: chiuderà gli anni ’70 con una commedia lieve, musicale, volutamente frivola.
Una coppia perfetta (
A perfect couple, 1979) è un piccolo film che cerca di analizzare l’amore da una prospettiva diversa, rispetto a Un matrimonio. Al posto della precedente coppia, quasi preordinata e forzata (e per questo già infelice e piena di dubbi) ne troviamo ora una assortita, improbabile, che per le diversità che la caratterizza rischia di essere, appunto, perfetta. E’ questo l’ennesimo schiaffo alle convenzioni cinematografiche e sociali che Altman assesta a pubblico e critica. Uno schiaffo lungo dieci anni e che continuerà per quasi altri trenta. Una storia di film realizzati per l’amore del fare più che per il desiderio di essere apprezzato. E il decennio che va dal ’70 al ’79 è sicuramente quello che ha meglio delineato lo stile, la caparbietà e l’incoscienza di uno dei registi più liberi di sempre.
“Quello che conta è l'atto di fare. Per me girare un film equivale a fare castelli di sabbia.
Si va in spiaggia con un gruppetto di amici e si costruisce un grande castello di sabbia.
Quando è finito ci si mette seduti a bere una birra aspettando l'arrivo delle onde.
Dopo venti minuti quello che riamane è solo sabbia.
La struttura che si era costruita è rimasta solo nella testa della gente...” Robert Altman (Tratto da Altman racconta Altman a cura di David Thompson)
APPROFONDIMENTO INSERITO DAL BENEMERITO
HACKETT

















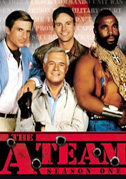

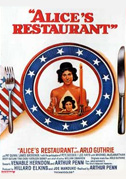

29 Novembre 2012 17:25
Un gran bel lavoro Hackett.
Mco
29 Novembre 2012 22:52
1 Dicembre 2012 02:20
8 Dicembre 2012 08:22
11 Gennaio 2013 21:20